22 Ottobre 2013
Se non fossero tra le tendenze più abusate del momento, l’autoproduzione e la rivalutazione dell’artigianato sarebbero le chiavi di lettura ideali del lavoro di Francesco Faccin. Ma proprio la recente popolarità di quest’approccio progettuale rende doverosa una premessa. Faccin, nato a Milano nel 1977, si occupa di artigianato da tempi non sospetti, e con una determinazione molto rara tra i designer della sua generazione. Il suo è un impegno da autentico ricercatore, e per lui il piano dell’indagine continua a giocare un ruolo essenziale a prescindere dagli esiti materiali dei singoli progetti. Per fare un solo esempio, Faccin ha appena inaugurato una mostra alla Triennale di Milano, Made in Slums. Mathare Nairobi, dedicata a una raccolta di oggetti molto particolari di cui non è autore, ma collezionista. Objets trouvés rinvenuti dove la saturazione del consumo produce i suoi effetti più nefasti. Uno slum africano che funge quasi da iceberg sommerso della nostra punta occidentale emersa. Un territorio sconosciuto ai più, dove però qualcosa tra i rifiuti si muove e, per fortuna, non si tratta solo di topi e parassiti.

Made in Slums. Mathare Nairobi, Triennale di Milano. Photo: Filippo Romano.
Ci parli di questa storia?
Mathare è una bidonville di Nairobi che ospita mezzo milione di persone, praticamente una città nella città della capitale kenyota. Ci sono andato nell’ottobre 2012, invitato dalla Ong Liveinslum, per disegnare e realizzare gli interni di una scuola. Frequentando ogni giorno la comunità, mi sono accorto che una miriade di bancarelle immerse nel fango esponevano merci che non avevo mai visto prima. Intendo oggetti d’uso quotidiano che gli artigiani dello slum assemblano, producono e vendono; cose che nascono letteralmente dalla spazzatura che invade tutto lo spazio circostante. Per assurdo che possa sembrare, un agglomerato come Mathare vive infatti “grazie” alla spazzatura, perché dove c’è scarto ci sono risorse riutilizzabili, non solo di cibo, ma soprattutto di materiale.
Cosa ne fanno?
Di tutto. In parte imitando oggetti di consumo industriale – secchi, annaffiatoi, pentole – e in parte creando nuove matrici. Il denominatore comune, comunque, è la necessità: in tutto quello che inventano o ricreano non c’è nessuna indulgenza alla decorazione.
Non credi che sia rischiosa la retorica del design per l’altro 90% del mondo? Invece di impegnarsi sul posto, in molti preferiscono rimanere nei loro studi e da lì spedire progetti nei paesi sottosviluppati.
Certo, perché poi vai là e ti accorgi che nello slum, per esempio, non c’è corrente elettrica, il che non è esattamente un dettaglio se devi realizzare dei mobili in legno. Bisogna lavorare con la sega a mano e con chiodi in alluminio che si piegano solo a guardarli, e questa penuria ti costringe a ridefinire l’intero processo di lavorazione puntando a evitare ogni spreco di materiale e di energie. L’elemento più importante del mio progetto probabilmente è stata una sorta di catena di montaggio costituita da una dima con vari blocchi di legno per tenere i listelli e incollarli nella posizione giusta. Ma non è che sono andato là semplicemente a portare la mia dima: l’ho costruita insieme a loro e ne ho spiegato il funzionamento a chi avrebbe dovuto utilizzarla. Ora mi mandano le foto della famiglia di oggetti sviluppata a partire da questo strumento.

Made in Slums. Mathare Nairobi, Triennale di Milano. Photo: Filippo Romano.
Quindi non si tratta del solito assemblaggio di pezzi riciclati, ma di un’economia parallela fatta di prodotti creati e replicati in base a una legge di domanda-offerta. Quanto è importante il concetto di necessità oggi?
Quella della necessità di un oggetto per le nostre vite penso sia l’unica vera domanda che dobbiamo porci da progettisti. Ci si continua ad arrovellare sulla crisi del sistema design, ma il problema non è il sistema in quanto produzione industriale o il fatto che si venda meno. Il design è in crisi perché non si sa più cosa sia necessario. Si pensa che un prodotto che vende sia un buon prodotto, ma questo tipo di ragionamento genera una grande confusione sul valore stesso delle cose.
Concretamente, tu che alternativa persegui?
Quando vengo chiamato a progettare qualcosa, che sia una carriola o un ristorante, cerco sempre di affrontare il lavoro in modo che il principale punto di interesse non sia l’oggetto finale, ma il processo. Come nel caso del ristorante 28 Posti a Milano: sono molto soddisfatto perché ho registrato pochissimi commenti sull’estetica degli arredi e moltissimi sul dietro le quinte, sul coinvolgimento dei detenuti di San Vittore nella realizzazione dei pezzi. Questa per me è una risposta all’assoluta mancanza di riflessione su che senso abbia progettare oggi. Il sogno poi è che ogni progetto sia la pagina di un racconto coerente, che ci sia un filo rosso oltre il singolo prodotto che si impone sul mercato.

28 posti. Photo: Filippo Romano.
Facciamolo allora questo tuo racconto. Come hai cominciato, che scuole hai fatto?
Innanzitutto lasciami dire che le scuole dovrebbero chiudere tutte: penso che per fare questo mestiere non sia assolutamente necessario frequentare una scuola. A contare è solo la possibilità di incontrare persone che vogliono fare il tuo stesso mestiere. In questo senso, lo IED di Milano è l’unica scuola davvero internazionale: qui ho conosciuto Alvaro de Ocón, che è diventato non solo il mio migliore amico, ma anche l’interlocutore con cui costruire un’idea “nostra” di design. Siamo stati complementari per tantissimo tempo, usando gli anni di formazione per divorare immagini, mostre, luoghi, viaggiando un po’ ovunque, da Londra al Sud America.
Che stili e che maestri ti hanno influenzato?
Ho avuto i miei innamoramenti, uno dei primi è stato quello per il Minimalismo. Poi la fase di severità eccessiva è passata e in un viaggio in Messico ho scoperto Luis Barragàn: un colpo di fulmine senza riserve. Non lo considero solo un architetto, ma un progettista a 360°, perché pensa alla casa come luogo della relazione tra esseri umani, come riflessione sulle proporzioni e gli spessori, sui materiali e la luce. È un maestro di complessità e attraverso il suo lavoro capisci che quando l’architettura è fatta bene non riguarda la forma degli spazi, bensì la vita che vi si svolgerà all’interno. Forse è per questo grado di complessità che ho cercato i miei maestri più tra gli architetti che tra i designer. Architetti in grado di progettare non muri, ma sensazioni.
Per esempio, chi altro?
Un progettista che mi ha cambiato la vita si chiama Giuseppe Galimberti ed è un architetto che ha trascorso tutta la sua esistenza in Valtellina, realizzando capolavori sconosciuti. È un Barragán del Nord Italia. Lavora con le strutture tradizionali, usando cemento e pietra in modo del tutto innovativo e costruendo case per clienti colti in grado di coglierne il senso. E non è mai sceso a valle, vive lassù con sua moglie e le capre, e su di lui non esiste nemmeno una traccia su Internet. Lì ho capito che si possono fare cose di grandissima qualità senza mettersi in mostra.
Come hai incontrato Enzo Mari?
Gli ho scritto una lettera, rigorosamente a mano, con tanto di francobollo. Ho scritto a lui perché è l’unico in Italia che incarna l’attenzione per il dettaglio, la qualità, il materiale e la conoscenza della tradizione da reinterpretare. Oltretutto a Milano era l’unico che lavorava senza usare il computer, strumento che anch’io odiavo. Così dopo due settimane mi arrivò la sua risposta scritta con pennarello nero, in cui mi invitava per una chiacchierata. L’incontro non andò affatto bene: demolì tutto quello che avevo fatto fino a quel momento, ma ripensandoci non aveva tutti i torti.

Enzo Mari. Photo: Jouko Lehtola.
Avrà salvato qualcosa…
Gli piacquero degli assemblaggi che facevo con i materiali di recupero, un lavoro più “artistico” che da designer. Al momento mi mandò via, crudo e netto come solo lui sa essere. Ma dopo una settimana mi richiamò e mi diede una possibilità: sei mesi a lavorare nel suo archivio, catalogando articoli su riviste e giornali con un sistema di schede a brevi sintesi che aveva messo a punto lui stesso. Alla fine, negli ultimi mesi, mi mise a lavorare sulla Mariolina di Magis. Ovviamente il tutto condito dalla sua proverbiale umoralità. Tanto che alla fine me ne andai convinto che non avrei mai fatto il designer.
E cosa pensavi di fare?
Cercavo un lavoro dove la qualità fosse più nel fare che nel pensare. Così sono andato a bottega da un artigiano. In realtà era un architetto che aveva fatto la scuola di liuteria di Cremona e aveva una visione “colta” dell’artigianato. Insieme abbiamo costruito moltissimi modelli architettonici: oggetti bellissimi, in legni masselli pregiati, fatti tutti a mano, lavorando in una filanda dell’800 dove regnava un’atmosfera decisamente rinascimentale.
E lì sei riuscito a non pensare?
Ho imparato a usare gli scalpelli, a lavorare solo con le mani senza pensare al progetto. Grazie a questa esperienza oggi il mio processo creativo passa per il costruire prima ancora che per il disegnare. D’altra parte io non lavoro col computer, e non sono così bravo da esprimermi compiutamente con il disegno, quindi l’approccio materiale del modello è quello che più mi si addice. Le cose devo costruirle per capirle, quindi mi capita spesso di creare gli oggetti senza disegnarli prima. Poi una volta che ho realizzato il prototipo lo traduco in disegno tecnico. Il tavolo Centrino, per esempio, prima l’ho costruito e solo dopo l’ho “progettato”. All’inizio vivevo questa modalità come un limite, mi sentivo una sorta di analfabeta del progetto. Poi ho capito che è semplicemente la mia forma mentis.
Quando hai cominciato a sentirti un designer?
Dopo il Salone 2010, quando ho partecipato al Satellite insieme ad Alvaro De Ocon: la sedia Stratos è stata presa da Danese, ho ricevuto l’attenzione della stampa e ho vinto il premio Design Report Award. Lì ho capito che potevo provarci.

Stratos, design di Francesco Faccin per Danese, 2011.
Ultimamente hai partecipato a molti progetti collettivi, nei quali il punto nodale è l’attivazione di relazioni. Hai sviluppato la capacità di metterti al servizio di un progetto corale, che poi è una qualità tipica dell’artigiano.
Per me la cosa fondamentale è trovare un approccio etico al progetto in cui sono coinvolto. Se mi chiamasse una banca a disegnare la sua sede, mi porrei la domanda di come farla nella maniera più etica possibile. Mi domanderei per esempio qual è il ruolo che ha oggi la banca in Occidente.
Come ha fatto un altro tuo maestro, Michele De Lucchi.
Michele è un designer molto più imprenditore, sebbene anche per lui sia cruciale la riflessione sull’artigianato. Ha la capacità non solo di accontentare il suo cliente, ma di diventare il suo cliente, di immedesimarsi in lui. Io però ho un’altra visione: credo che nelle proprie scelte non si debba essere trasversali, ma radicali. In sostanza cerco clienti che mi diano l’opportunità di raccontare il mio racconto.
Ma allora perché ti sei rivolto a De Lucchi?
Perché avevo deciso che volevo incontrare l’industria, che non mi bastava più la dimensione artigianale. E in Italia Michele mi sembrava il progettista più a cavallo tra artigianato e industria. Inutile dire che l’ho contattato scrivendo una lettera a mano anche a lui.
Perché secondo te oggi tutti parlano di artigianato?
Con il sistema industriale completamente in crisi, l’unico modo per continuare a produrre oggetti è rivolgersi a chi conosce i materiali e può realizzare progetti. Se le porte dell’industria sono chiuse, quella dell’artigianato è l’unica alternativa. Gli artigiani sono i soli ad avere ancora competenze reali.
Si parla di artigianato e si mettono insieme cose molto diverse tra di loro: il fenomeno dei makers, delle stampanti 3D. Cosa ne pensi?
È una nuova forma di produzione, ma probabilmente non è corretto parlare di artigianato. Non sappiamo come si evolverà questo fenomeno, da questo punto di vista siamo ancora all’età della pietra. Comunque mi sembra ridicolo pensare che un giorno ci stamperemo in casa il nostro frigorifero personale. Se non altro perché quel giorno il frigo stesso sarà molto probabilmente un prodotto obsoleto, sostituito da chissà cosa.

Francesco Faccin per “Why not” Academy. Photo: Filippo Romano.
Quindi industria in crisi, artigianato in crisi. Qual è la terza via?
Se parliamo dell’artigianato duro e puro, quello altamente specializzato ma senza progettista, allora è naturale che sia entrato in crisi. Faccio un esempio: quest’anno a Roma ho lavorato su una mappatura sistematica dei laboratori artigianali di qualità. Grazie a questo lavoro ho aperto gli occhi su una realtà dura e difficile da accettare: fino a qualche tempo fa l’artigiano era al servizio di un tessuto urbano che aveva un bisogno continuo di aggiustare cose e comprarne di nuove, mentre oggi lavora quasi solo per i turisti. Quello del cestaro era veramente un servizio, fabbricava cesti per mettere la biancheria quando si faceva il bucato, non per vendere ai turisti un bel cesto per la frutta. Quindi oggi certi mestieri artigiani sono morti perché sono morte le esigenze che li tenevano in vita. È chiaro poi che le nicchie sopravvivono: la Chiavarina resisterà in quanto prodotto di altissima qualità, un’eccellenza unica al mondo. Ma è e deve essere una rarità, non la norma.
Oggi come oggi cosa ti piacerebbe disegnare?
Non ho una tipologia di oggetto prediletta. Più le cose mi fanno paura e più penso di doverle affrontare. In questo senso la cosa che mi è più estranea è il computer, ma se dovessi progettarne uno accetterei la sfida e mi metterei a studiare. Perché di solito è in queste situazioni “scomode” che fai il salto verso qualcosa di veramente diverso. Anche quando mi hanno offerto di andare in Africa a disegnare e realizzare gli arredi di una scuola di periferia, o quando mi hanno detto di fare un lavoro in carcere a Bollate, ero terrorizzato.
Quanto il materiale influenza il progetto? Penso non solo ai tuoi tanti oggetti in legno, ma anche a delle ciotole fatte con una straordinaria bio-plastica derivata dagli scarti della lavorazione del riso…
Credo che il materiale debba determinare la forma delle cose, e anzi non sopporto quando certi materiali vengono traditi. Penso per esempio a due edifici di Roma, molto vicini l’uno all’altro, il Palazzetto dello Sport di Pier Luigi Nervi e il MAXXI di Zaha Hadid. In quest’ultimo, il cemento è stato usato in maniera del tutto impropria, imponendogli di fare uno sforzo per sostenere le forme finali volute dall’architetto. Nel caso di Nervi, invece, il cemento è autoportante, è progettato in quella forma per ragioni statiche. Ecco, per me il massimo si ha quando estetica e struttura coincidono o, meglio, quando l’elemento strutturale è bello proprio sfruttando le naturali potenzialità del materiale.

Made in Slums. Mathare Nairobi, Triennale di Milano. Photo: Filippo Romano.

Made in Slums. Mathare Nairobi, Triennale di Milano. Photo: Filippo Romano.

Centrino, design di Francesco Faccin per Bolia, 2011.
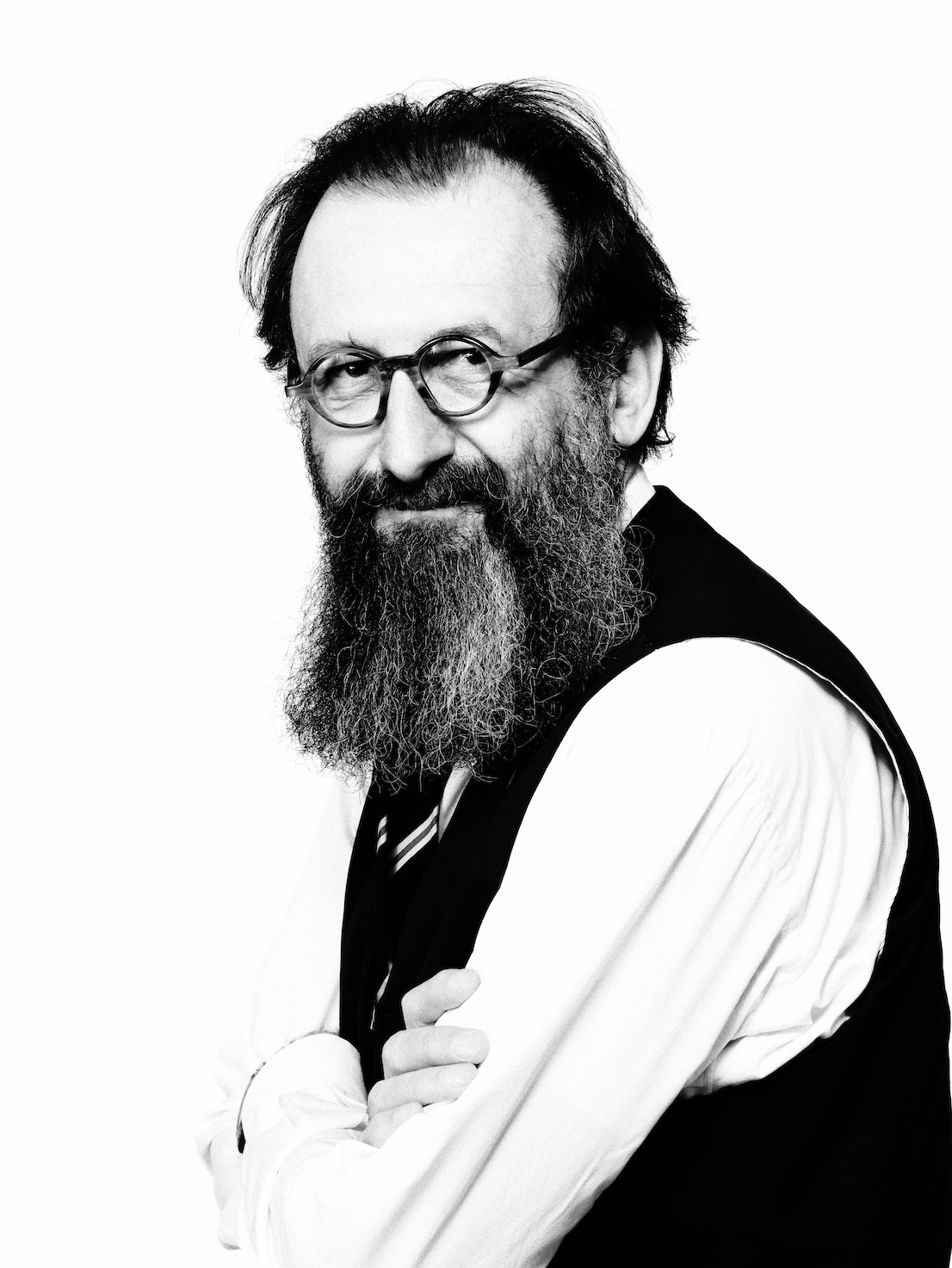
Michele De Lucchi. Photo: Giovanni Gastel.

Made in Slums. Mathare Nairobi, Triennale di Milano. Photo: Filippo Romano.

Made in Slums. Mathare Nairobi, Triennale di Milano. Photo: Filippo Romano e Francesco Giusti.

Made in Slums. Mathare Nairobi, Triennale di Milano. Photo: Filippo Romano e Francesco Giusti.

Made in Slums. Mathare Nairobi, Triennale di Milano. Photo: Filippo Romano e Francesco Giusti.

Made in Slums. Mathare Nairobi, Triennale di Milano. Photo: Filippo Romano e Francesco Giusti.

Made in Slums. Mathare Nairobi, Triennale di Milano. Photo: Filippo Romano e Francesco Giusti.