23 Ottobre 2017
Andrew Sean Greer (Washington DC, 1970) è autore di sette romanzi, tra cui Le confessioni di Max Tivoli, La storia di un matrimonio e Le vite impossibili di Greta Wells. L’ultimo, Less, è uscito lo scorso luglio negli Stati Uniti e ora arriva in Italia, pubblicato da La Nave di Teseo. Dal 2016 è direttore esecutivo della Santa Maddalena Foundation, una residenza per scrittori su una collina a 40 chilometri a est di Firenze. Abita a San Francisco e ama fare viaggi intorno al mondo.
“Forse la città migliore per trascorrere un fine settimana con gli amici è Città del Messico. Ti senti come se stessi scoprendo luoghi in cui non è mai stato nessuno. Non è una città per turisti, è per le persone che la abitano. Appena c’è un gruppo che suona la samba dal vivo, tutti vanno a ballare e non si preoccupano se tu – nordamericano o europeo – fai lo stesso”.
E la città più adatta per chi si muove da solo?
Quando viaggio da solo, non cerco compagnia. Mi siedo a un tavolo e prendo un cocktail. A Kyoto era perfetto, per i giapponesi non è strano che uno si muova per conto proprio.
Sei anche fan del Burning Man, vero? Quando ci sei stato per la prima volta?
Nel 2005, con la mia cara amica Soo. Non conoscevo nessun altro del gruppo e non ero a mio agio.

Però ti è piaciuto.
No, l’ho odiato!
Come?
Ora tutti vogliono andare ai festival, ma un tempo i festival erano poco attraenti. L’attitudine hipster di New York non funziona al Burning Man: ironia, sarcasmo, non puoi essere così da quelle parti. Io e i miei amici abbiamo preso in giro il Burning Man per anni, poi ci sono andato e non c’era nessuno con cui sedermi e deriderlo. Questo è il motivo per cui non mi è piaciuto. Ma ci sono tornato.
Perché?
In qualche modo ho capito che il problema ero io. Mi ero avvicinato al Burning Man in modo del tutto sbagliato. Non avrei dovuto isolarmi o proteggermi, ma semplicemente lasciarmi andare.
Ti ha cambiato?
Direi di sì. Giudico meno. Uno dei suoi principi è l’inclusione totale, che è difficile. Per vivere al meglio il Burning Man devi frenare l’impulso a prendere in giro un certo tipo di persone, devi metterti in discussione.
In questi ultimi anni sembra che tutte le persone alla moda amino andarci.
È vero. Per due decenni in molti lo hanno deriso e snobbato, poi ha trovato una propria strada, una propria identità, e tutti adesso vogliono esserne parte – il che di solito rovina tutto.
Ma lo spirito del Burning Man è ancora vivo.
Perché è una città che viene costruita ogni anno. A differenza di un luogo come New York City, dove ogni zona può essere occupata, riqualificata e perduta per decenni.
Hai mai abitato a New York City?
Sì, mi ci sono trasferito nel 1992, dopo l’università, quando non era di moda e non era bella, sebbene tutto fosse caro. Vivevo nel West Village perché potevo permettermi solo quello. Nessuno abitava a Brooklyn.
Perché il West Village era così economico?
Perché era il quartiere gay e le persone eterosessuali non volevano viverci, così c’erano un sacco di appartamenti vuoti.
Avevano paura dell’HIV?
No, solo di essere derisi per il fatto di abitare in un quartiere gay.

Ti piaceva vivere a New York?
Ero molto infelice e miei amici dicevano che per sopravvivere dovevo diventare più coriaceo, ma non era semplice. Incontri migliaia di persone al giorno, quindi per forza devi avere una protezione di qualche genere. Dovevo costruirmela, oppure mi avrebbero mangiato vivo. Avevo 21 anni.
È questo il motivo per cui sei finito San Francisco?
Sì, ma dopo essermi laureato in scrittura creativa all’Università del Montana, a Missoula, e dopo aver vissuto due anni a Seattle.
Perché Seattle?
Era la città più grande vicino a Missoula, e mi incuriosiva. All’epoca era alla moda e grunge essere là. Era il 1996. Kurt Cobain era morto due anni prima. Non avevo soldi, non uscivo mai e la odiavo. Odiavo Seattle, è stato un errore nella mia vita.
Un errore più grande di New York?
Decisamente. New York offriva molte possibilità, ero io a non essere in grado di afferrarle. Seattle non aveva nulla da darmi. Non riuscivo a farmi degli amici, non riuscivo a trovare un ambiente di scrittori. Nulla. Mio fratello gemello Mike viveva a San Francisco e un’estate sono andato a fargli visita. Sapevo che l’avrei amata, mi ci sono trasferito nel 1998.
Com’era San Francisco nel 1998?
C’erano molti artisti, una grande comunità di scrittori. Era meraviglioso.
Una comunità di scrittori più grande di quella di New York?
A New York era molto difficile incontrare altri scrittori perché tutti, in qualche modo, proteggevano il loro piccolo mondo. E comunque, a un certo punto, molti scrittori si sono trasferiti da New York a San Francisco, formando un gruppo molto aperto e collaborativo. Nei bar e nelle vecchie librerie si presentavano libri di continuo. Per me quello era il paradiso.
Fammi alcuni nomi.
Michael Chabon, Daniel Handler, Dave Eggers e scrittori underground come Michelle Tea, ancora molto influente negli Stati Uniti. È stato incredibile incontrare scrittori come lei, che non aspiravano alla fama, ma volevano cambiare il mondo.
Hai visitato il nuovo San Francisco MoMA?
Certo. Quando l’ho visto ho subito pensato: finalmente, San Francisco è una delle grandi città del mondo. Non abbiamo mai avuto un museo del genere in città, e ciò mi ha reso felice perché è riuscito a compensare quello che in questi anni è andato perduto. Perdi gli artisti, arrivano i musei.
Forse oggi ci sono più progettisti?
Sì, arrivano direttamente dal mondo dell’ingegneria e della tecnologia. La maggior pare dei miei amici sono progettisti e trovano questa città molto vivace dal punto di vista creativo.
E cosa mi dici del nuovo Bay Bridge?
Il vecchio ponte doveva essere sostituito per ragioni legate ai terremoti, quindi è stato presentato un progetto, ma Schwarzenegger, all’epoca governatore, disse: “Troppo caro, avete solo bisogno di un ponte, non deve per forza essere bello”. Abbiamo protestato e infine ottenuto un ponte molto bello. I ponti sono una delle poche cose capaci di dare la sensazione di grandiosità e noi a San Francisco lo sappiamo, perché abbiamo uno dei ponti più famosi del mondo: il Golden Gate, dove vado a nuotare tutte le mattine.
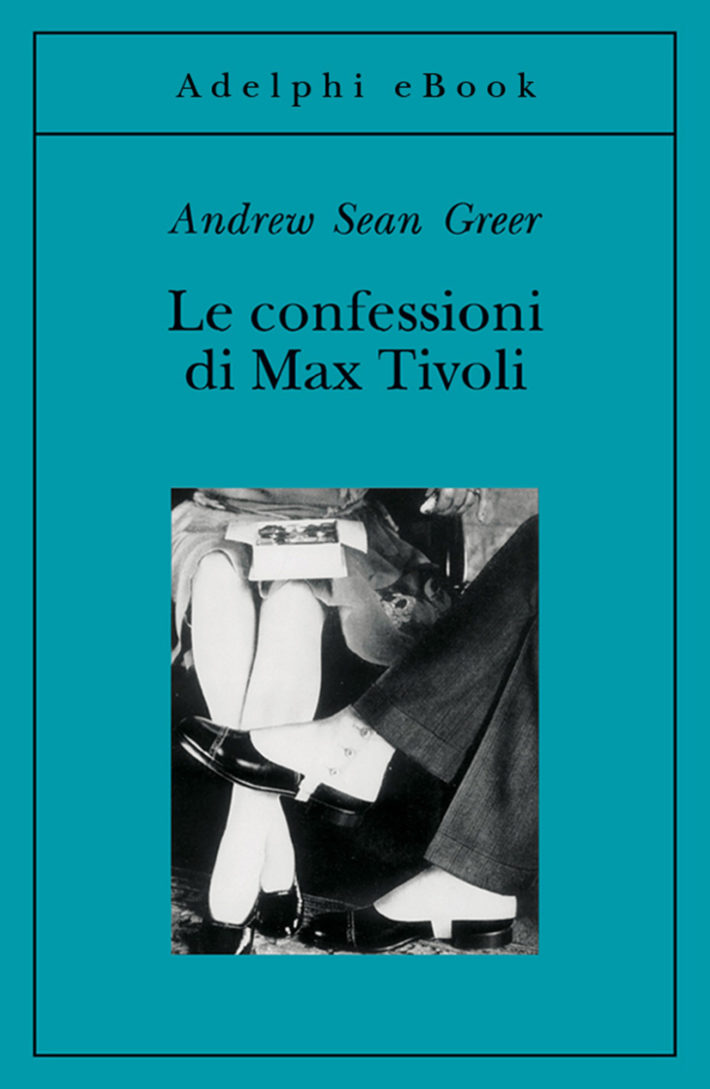
I ponti ti piacciono parecchio.
Molto. Qualche anno fa sono andato a presentare il mio romanzo Le confessioni di Max Tivoli a Redding, in California, una città in mezzo al nulla. La giovane donna che gestiva l’evento mi ha accompagnato a vedere un ponte pedonale progettato da Santiago Calatrava, donato alla città da una coppia facoltosa. Le persone non erano d’accordo: avevano bisogno di una nuova biblioteca, non di un ponte sopra un fiume che non porta da nessuna parte. Adesso però i turisti vanno a Redding solo per vedere quel ponte. La giovane donna mi ha detto che quando lo vide per la prima volta fu quasi una rivelazione: capì che nel mondo si poteva costruire qualcosa solo a fini estetici, per bellezza, per procurare piacere. Che è il motivo per cui facciamo arte. L’arte ti trasforma.
L’inizio de Le confessioni di Max Tivoli è ora una frase che appare negli annunci di nozze: “Siamo tutti il grande amore di qualcuno”. Come ti senti quando frasi come questa diventano così popolari?
Beh, a chi non piacerebbe? Trovo molto lusinghiero che sia usata a una cerimonia di nozze. Ma credo di avere una percezione diversa di quella frase. Cosa succede se qualcun altro è l’amore della tua vita?
Le confessioni di Max Tivoli racconta la storia di un uomo che invecchia al contrario. Una storia ispirata al brano di Bob Dylan My Back Pages. Che reazione hai avuto quando ha vinto il Premio Nobel per la letteratura?
La mia prima reazione è stata: “Questo è fantastico!”. Tutti sappiamo che i premi ogni tanto devono andare a qualcuno su cui il pubblico è d’accordo. Io posso pensare che Leonard Cohen sia uno scrittore migliore – non era ancora morto – o Joni Mitchell, ma Bob Dylan è più popolare.
La scorsa estate negli Stati Uniti è uscito il tuo ultimo libro, Less, appena pubblicato anche in Italia.
Less è completamente diverso dagli ultimi libri, tutti malinconici e commoventi. Alcuni sono una sorta di esperimento mentale, qualcosa di eccentrico. Questo è una commedia.
Eri stanco di scrivere tragedie?
Credo che la commedia sia semplicemente l’altro lato della tragedia: gli stessi eventi visti da una lunga distanza e raccontati con senso dell’umorismo. In una commedia accadono cose terribili: le persone falliscono, fanno errori, alcuni di loro perdono l’amore, altri lo ritrovano. Tutte queste cose possono essere una tragedia, lo sperimentiamo nella nostra vita. Se però riusciamo a cambiare il nostro punto di vista, possono diventare divertenti. Questo è ciò che è accaduto con questo libro. L’ho iniziato che stava per essere un’altra tragedia e poi ho cambiato idea.
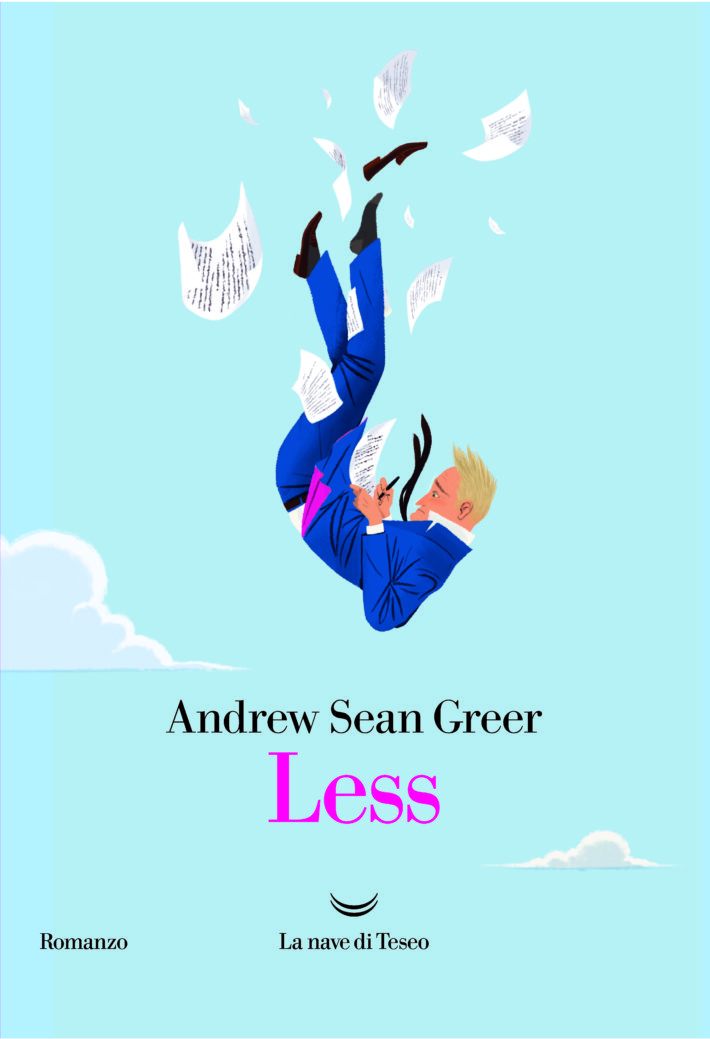
Il titolo è il cognome del protagonista.
Sì, Arthur Less. Per la prima volta ho anche scelto il soggetto della copertina, illustrata da Leo Espinosa, e ho pensato alle illustrazioni interne.
Dello stesso artista?
No, quelle sono di Lilli Carré. Volevo che illustrasse ciascun capitolo con una immagine che non fosse quella principale, privilegiando aspetti secondari. Credo che questo aggiunga una punta di mistero alla lettura.
Hai suggerito tu queste immagini?
Le ho detto esattamente cosa volevo che fosse illustrato. È un libro che parla di un uomo che viaggia attraverso il mondo, ma non volevo che il capitolo del Messico avesse un sombrero. C’è un capitolo in India che ha l’immagine di un ago da cucito, quindi tu lo guardi e pensi: “Cosa accadrà?”.
Di certo non è il classico libro di viaggio.
Ogni capitolo è ambientato in un paese diverso, ma il viaggio è utilizzato solamente in funzione della storia.
Per metà dell’anno tu sei in Toscana, dove ricopri il ruolo di direttore esecutivo della Santa Maddalena Foundation, il cui presidente è Beatrice Monti della Corte, ex proprietaria della Galleria dell’Ariete a Milano – chiusa nel 1993. I dipinti hanno qualche impatto sul tuo lavoro?
Sì, hanno un impatto molto forte. C’è un intero corridoio alla Fondazione con le locandine delle mostre ospitate nella galleria milanese, tutte realizzate dai singoli artisti: Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Cy Twombly, e gli italiani naturalmente. Credo che per gli scrittori sia importante avere un’altra forma d’arte in cui perdersi. Quando rimani intrappolato nel tuo mondo, puoi uscire per una lunga camminata. Io se osservo un dipinto trovo una via d’uscita.
Conoscevi gli artisti italiani passati dalla Galleria dell’Ariete?
Non molto, ma voglio raccontarti un aneddoto. L’anno in cui sono stato per la prima volta alla Fondazione, nel 2005, è morto Piero Dorazio. Sono stato al suo funerale e lì ho conosciuto alcuni artisti italiani. Tre anni dopo, ero in un mercato di strada ad Arezzo, Beatrice ha visto un dipinto su una bancarella e ha sussurrato: “È un Dorazio”. Chi stava dietro il banco non sapeva che lo fosse, così ora io possiedo un Dorazio.
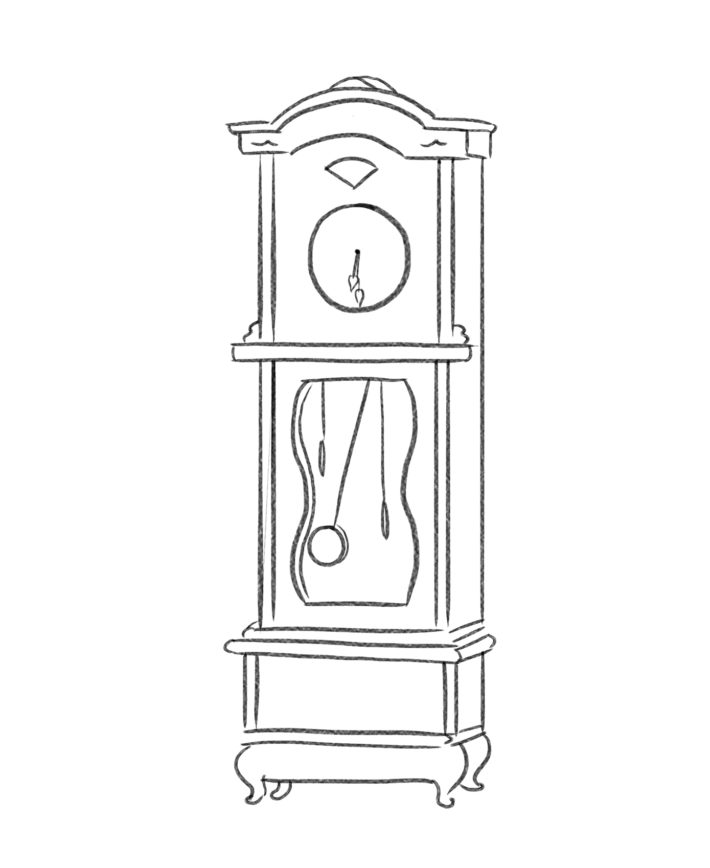
Illustrazione di Lilli Carré, tratta da Less.

Illustrazione di Lilli Carré, tratta da Less.
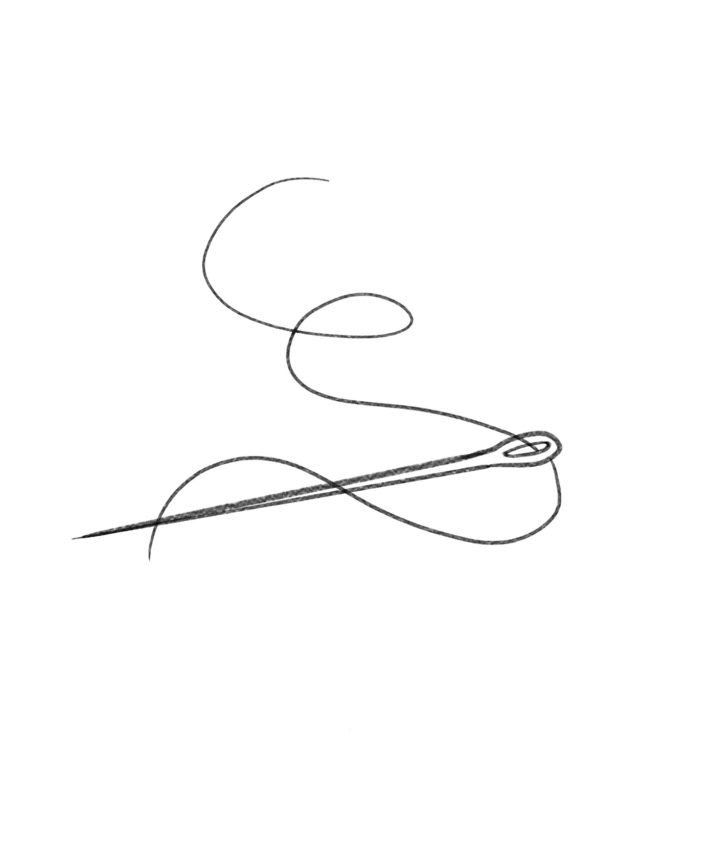
Illustrazione di Lilli Carré, tratta da Less.
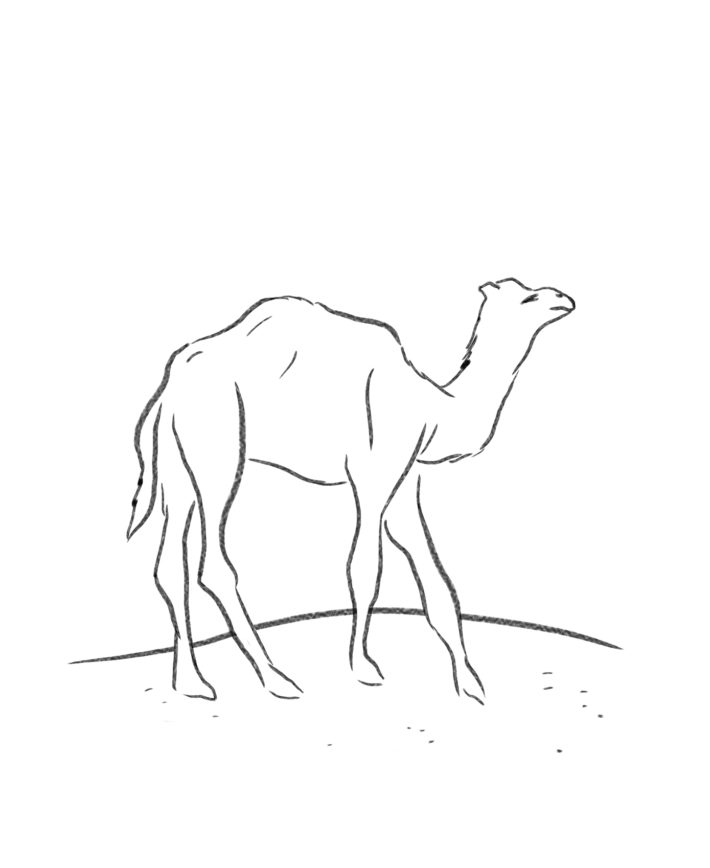
Illustrazione di Lilli Carré, tratta da Less.
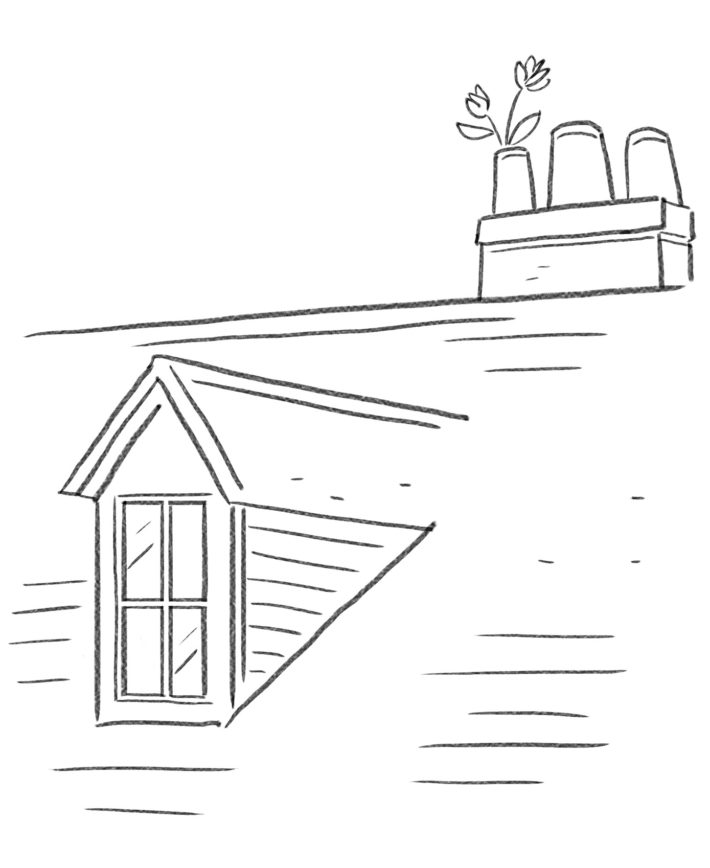
Illustrazione di Lilli Carré, tratta da Less.
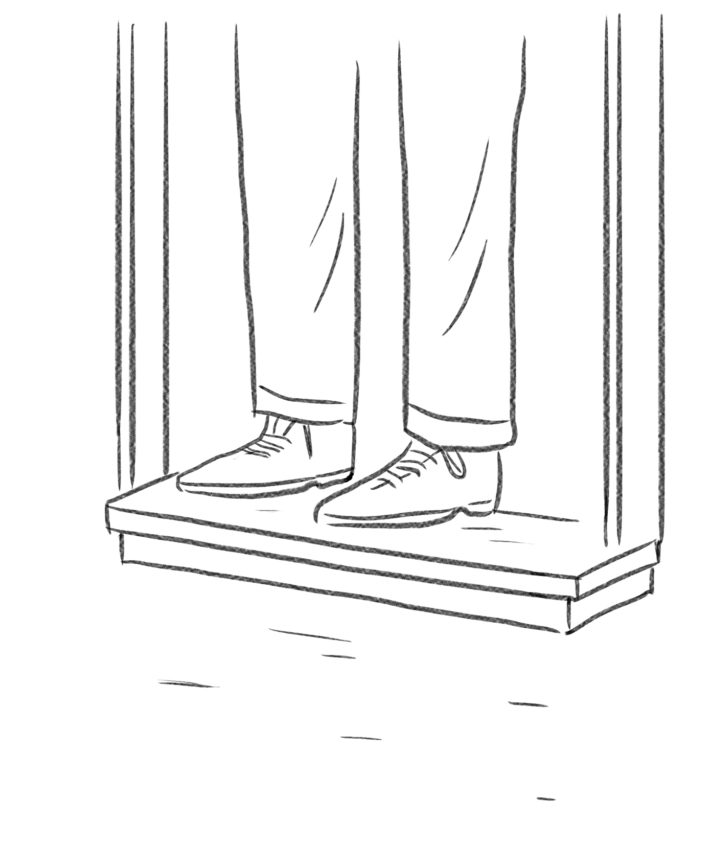
Illustrazione di Lilli Carré, tratta da Less.

Illustrazione di Lilli Carré, tratta da Less.

Illustrazione di Lilli Carré, tratta da Less.